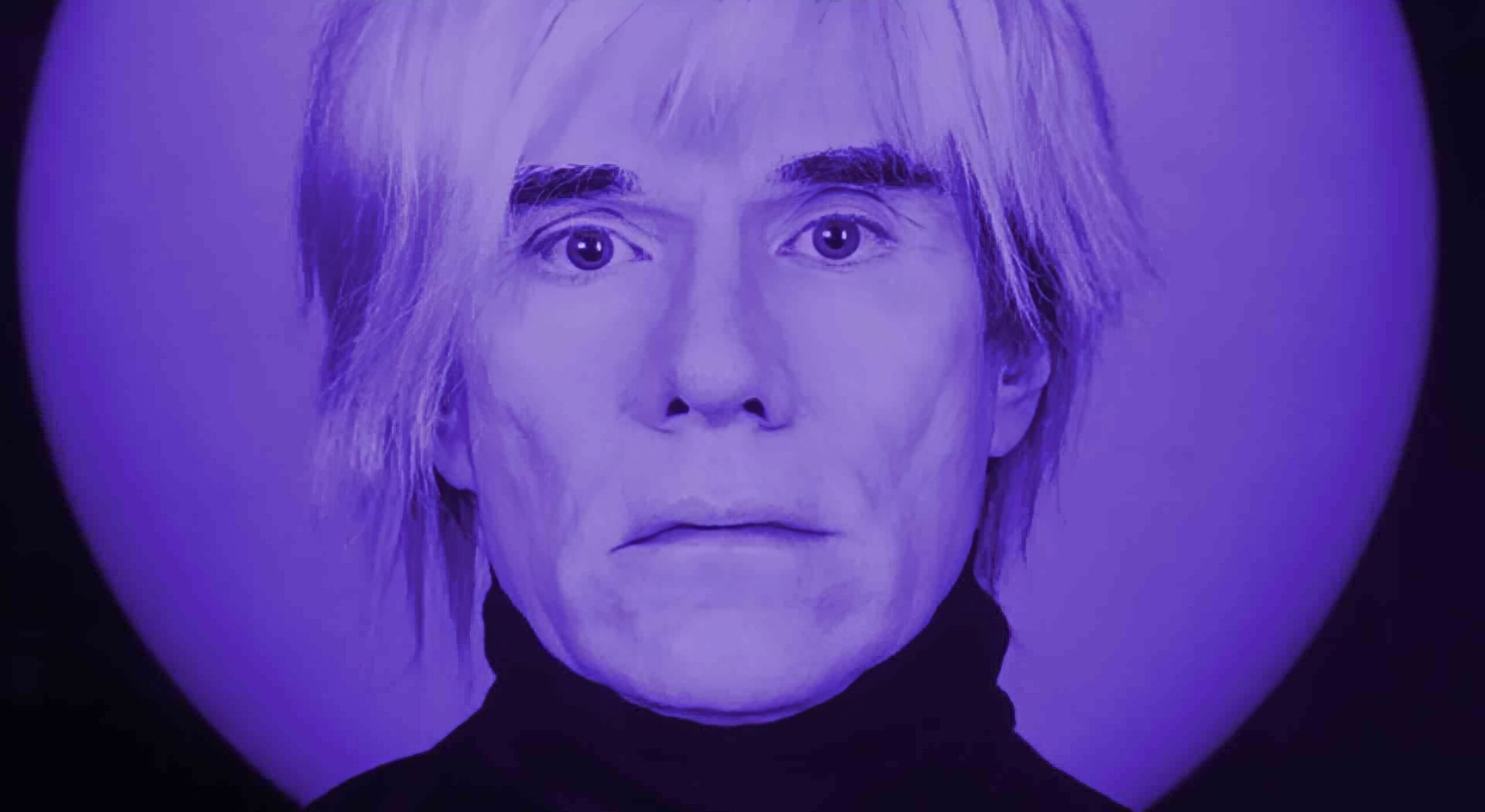Usufrutto e nuda proprietà: quando scatta la tassazione
La recente normativa fiscale ha chiarito un punto importante per chi vende un immobile suddividendo i diritti tra nuda proprietà e usufrutto a favore di due acquirenti distinti:
in questo caso non si applica automaticamente la tassazione come “redditi diversi” per il venditore.
Si paga soltanto se si realizza una plusvalenza (cioè un guadagno) e solo quando ricorrono determinate condizioni temporali.
Con l’interpretazione autentica introdotta dal Decreto Fiscale (Dl 84/2025), in vigore retroattivamente dal 2024, il legislatore ha chiarito come distinguere i casi in cui la cessione di un diritto reale (come l’usufrutto) genera:
- Redditi diversi → tassati subito, indipendentemente da quanto tempo si è posseduto l’immobile;
- Plusvalenze → tassate solo se l’immobile è ceduto entro 5 anni dall’acquisto (con alcune eccezioni).
La regola chiave
- Se il venditore mantiene un qualsiasi diritto sull’immobile, il guadagno rientra nei redditi diversi (tassazione ordinaria IRPEF o IRES).
- Se invece perde ogni diritto sull’immobile, si parla di plusvalenza (tassata, se dovuta, con imposta sostitutiva del 26% o IRPEF ordinaria).
Esempi pratici
- Caso 1: vendo solo l’usufrutto ma conservo la nuda proprietà → Reddito diverso, tassazione immediata.
- Caso 2: vendo sia nuda proprietà che usufrutto a due persone diverse, rinunciando a ogni diritto → si applicano le regole della plusvalenza.
Vendita dell’intero immobile da parte di persona fisica (non imprenditore)
Se vendi un immobile per intero (quindi cedi ogni diritto) e:
- lo hai posseduto per più di 5 anni → nessuna tassazione (art. 67, comma 1, lett. b) TUIR);
- lo hai ereditato → nessuna tassazione, anche se venduto prima dei 5 anni;
- è stato la tua abitazione principale (per te o per i familiari) per la maggior parte del periodo tra acquisto e vendita → nessuna tassazione, anche se prima dei 5 anni.
Pagheresti invece imposte (plusvalenza) se:
- vendi entro 5 anni dall’acquisto,
- e non rientri nelle eccezioni sopra.
In tal caso, la plusvalenza è tassata con IRPEF ordinaria o, se lo chiedi al rogito, con imposta sostitutiva del 26%.
In sintesi
Se vendi l’intero diritto su un immobile, anche frazionandolo tra più acquirenti, la tassazione segue le regole della plusvalenza.
- Se mantieni una parte del diritto, il guadagno è trattato come reddito ordinario e tassato subito.
- Nei casi di vendita entro 5 anni, senza eccezioni, la plusvalenza è imponibile.
- In operazioni complesse, una valutazione preventiva con un consulente può evitare sorprese fiscali.