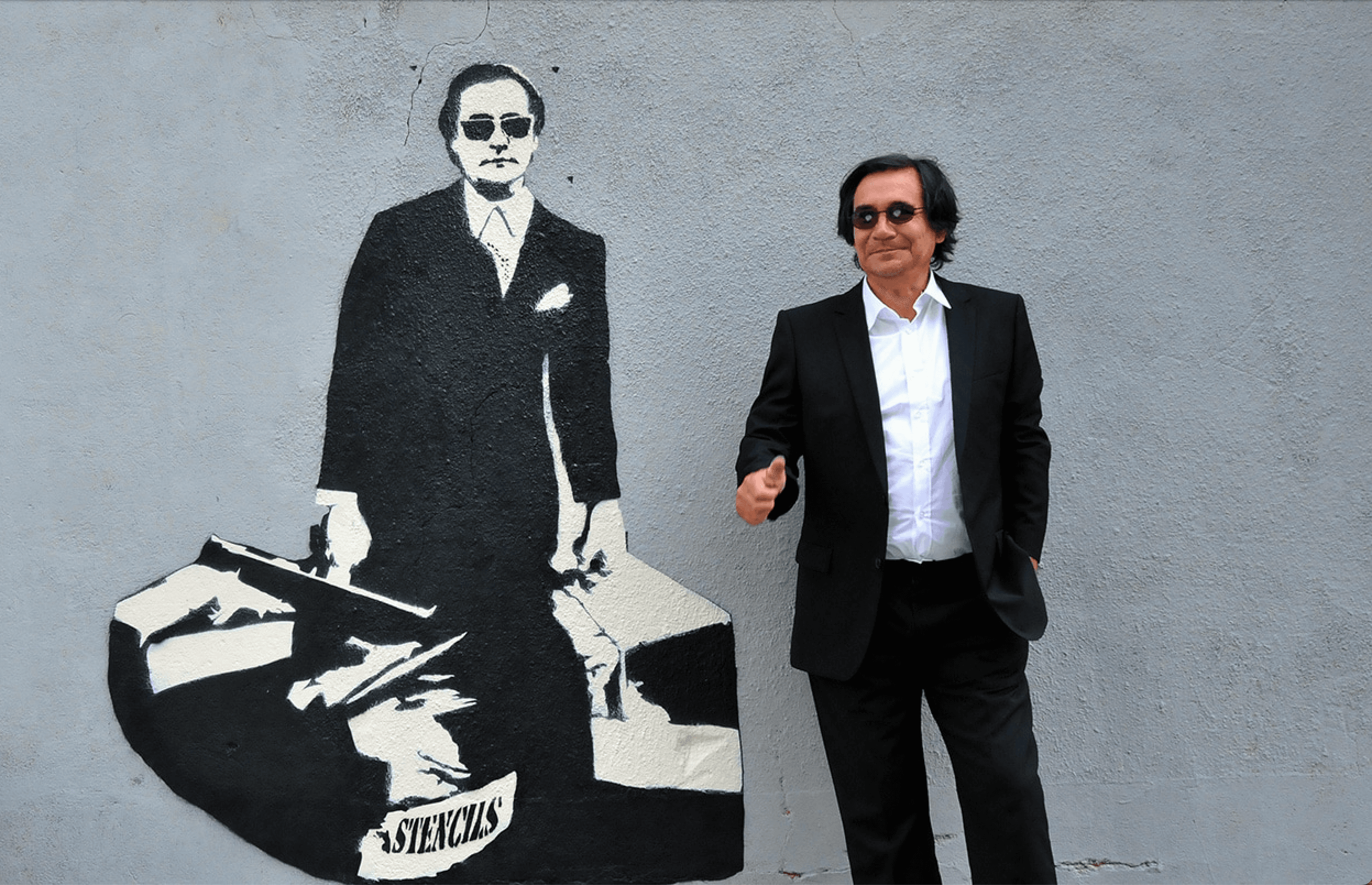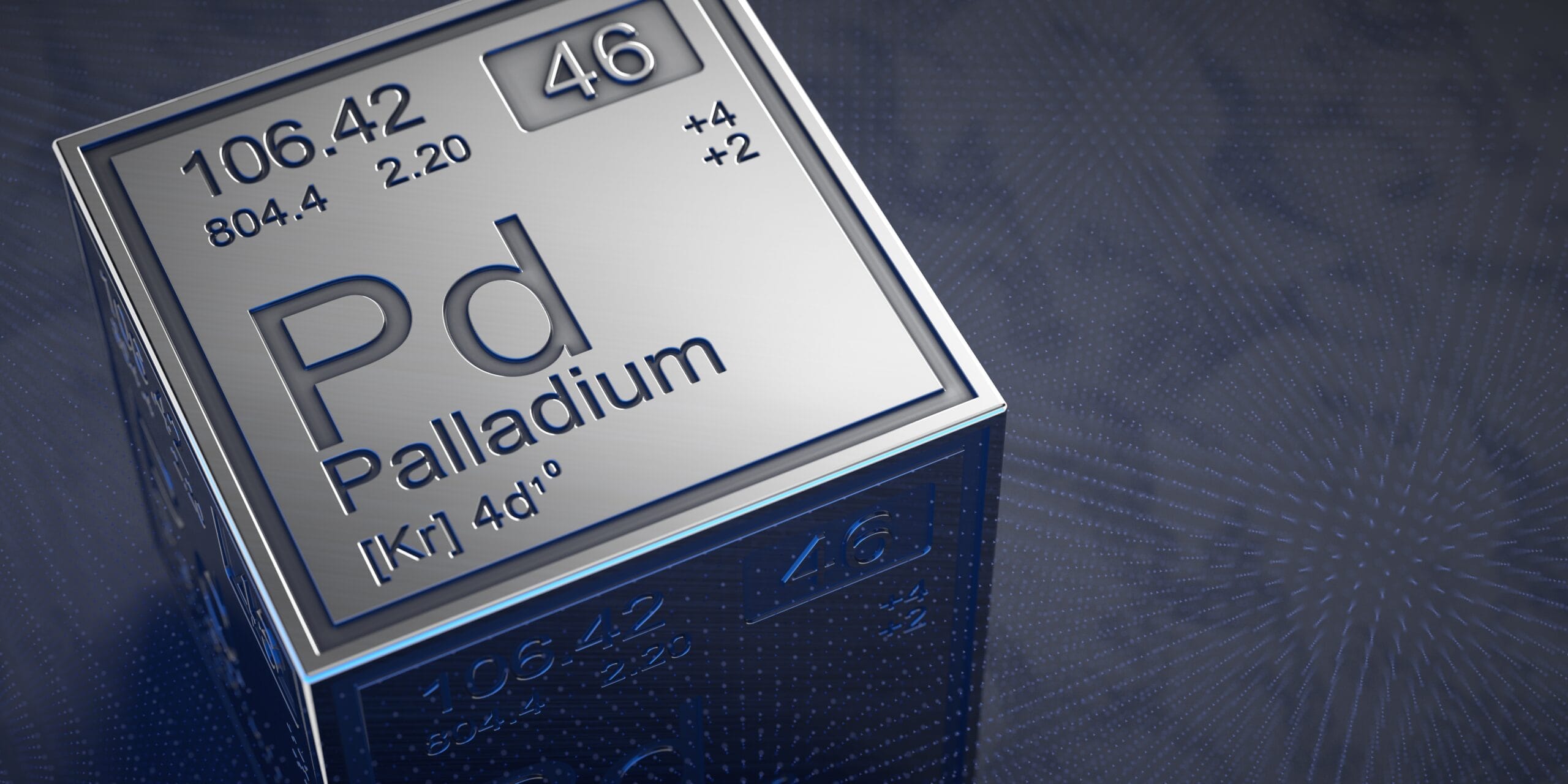C’è un filo rosso che unisce conti pubblici, politica monetaria e mercati: l’America spende molto, si finanzia senza tregua e paga interessi sempre più pesanti. A fine 2° trimestre 2025 il debito federale totale era 36,21 trilioni di dollari (serie FRED), mentre il debito “held by the public” superava 28,98 trilioni; su base PIL, parliamo di circa 119% per il debito totale e 95% per la sola quota detenuta dal pubblico. Sono livelli alti, consolidati e difficili da invertire senza scelte di politica fiscale molto nette.
Il flusso di “rosso”: deficit, voci in entrata e in uscita
Ad agosto 2025 il deficit mensile si è attestato a 345 mld (−9% a/a), complice il boom dei dazi che ha gonfiato gli incassi doganali. Con un mese alla fine del FY, il disavanzo cumulato era ~$1,97 tn, e le stime di consenso per l’intero esercizio ruotano attorno a $1,8–1,9 tn. Dietro i numeri, i tracker di CBO/BPC mostrano un quadro coerente: entrate in crescita (record storico YTD) ma spese che crescono quasi allo stesso ritmo, con interessi, Social Security e Medicare tra i driver. Nel documento TBAC di luglio si vede bene la composizione: dogane in forte aumento, istruzione in calo per effetti una tantum 2024, Tesoro in su per il maggior costo degli interessi.
Quanto scade (presto) e perché conta
Il problema non è solo “quanto” ma “quando”. La scadenza media del debito negoziabile resta corta per un emittente G7: fonti ufficiali e parlamentari collocano l’average maturity intorno a 72 mesi a metà 2025, in lieve allungo rispetto a un anno prima ma non abbastanza da “disaccoppiare” il costo medio dai tassi correnti. Inoltre, circa il 31% del debito negoziabile in mano al pubblico maturerà entro 12 mesi: una “maturity wall” che obbliga il Tesoro a rifinanziare volumi ingenti trimestre dopo trimestre.
Questa parete corta è anche frutto della scelta (razionale) di usare molti Treasury bills per ricostituire cassa e assorbire fabbisogni: nella presentazione TBAC il caso base fissa la quota Bills al 20,7% (luglio 2025) nei percorsi “prorated”. Più Bills significa flessibilità e domanda naturale dai fondi monetari, ma anche maggiore velocità con cui i tassi di mercato si trasferiscono sul costo medio del debito.
Cosa sta facendo il Tesoro (e cosa intende fare)
1) Guidance e stime di borrowing. Nella finestra luglio–settembre 2025 il Tesoro ha indicato $1,007 tn di emissione netta (privately-held) e un TGA (cassa) a $850 mld a fine settembre; per ottobre–dicembre 2025 la stima è $590 mld netti, sempre con target cassa $850 mld a fine trimestre. Sono numeri che ancorano le aspettative del mercato e spiegano perché l’offerta di carta USA vada considerata “strutturale”.
2) Mix d’offerta e TIPS. Nelle ultime Quarterly Refunding i dealer si aspettavano taglie stabili su nominali e FRN, con incrementi graduali sui TIPS (riapertura 10Y di settembre +$1 mld; nuovo 5Y di ottobre +$1 mld). L’obiettivo è ampliare e “fissare” una base d’investitori più sensibile all’inflazione, senza stressare troppo le scadenze lunghe nominali.
3) Programma di buyback. Dal maggio 2024 è operativo un buyback regolare su titoli off-the-run per sostenere la liquidità del secondario. La schedule pubblicata a fine luglio dettaglia operazioni su TIPS 1–10 anni e su nominali 1 mese–30 anni, con massimi per asta tra $0,5 e $4 mld a seconda dei bucket. È un “paracadute” anti-frammentazione: aiuta quando si formano “lacune” di liquidità su specifici CUSIP.
La domanda: chi compra? (E cosa guardano gli esteri)
La colonna estera resta importante. A luglio 2025 le detenzioni estere hanno toccato un record storico ($9,159 tn), trainate da Giappone e Regno Unito, mentre la Cina ha ridotto ai minimi dal 2008. È un segnale doppio: da un lato la “core demand” per il safe asset globale è viva; dall’altro la composizione geografica si sposta e può diventare più volatile nel tempo.
Anche alle aste primarie, la TBAC monitora la componente estera: la presenza c’è, ma non è un rubinetto infinito. Da qui l’importanza dei buyback (per il secondario) e di un profilo di offerta prevedibile (per il primario).
La cornice di politica monetaria: QT, RRP e SRF
La Fed ha rallentato il QT due volte: dal giugno 2024 il cap sui Treasury è sceso a $25 mld/mese, e dal 1° aprile 2025 è stato ulteriormente ridotto a $5 mld/mese (cap MBS invariato a $35 mld, con reinvestimento dell’eccesso in Treasury). Contemporaneamente, l’uso della RRP si è sgonfiato quasi a zero dai picchi 2022, segno che il “cuscinetto” di liquidità si è trasferito verso Bills e riserve bancarie. A metà settembre, in corrispondenza di scadenze fiscali/settlement, la Standing Repo Facility ha visto un utilizzo record ($18,5 mld): nulla di sistemico, ma un promemoria che, con RRP drenata, è la SRF a fare da valvola di sicurezza.
Il conto degli interessi: la voce che corre più veloce
Nel 2025 il governo ha già speso circa $1,1 trilioni in interessi (YTD ad agosto). Questo dato, aggiornato dal portale ufficiale del Tesoro, è il termometro migliore per capire quanto la “maturity wall” e i tassi reali alti stiano cementando coupon più onerosi nel portafoglio. È anche il punto su cui convergono le agenzie di rating quando parlano di “erosione del margine di manovra”.
Rating e governance fiscale
Sul fronte reputazionale, il quadro è chiaro: Fitch ha confermato AA+ (outlook stabile) il 22 agosto 2025; Moody’s ha declassato a Aa1 il 16 maggio 2025 (outlook stabile). Tradotto: gli Stati Uniti restano emittente di altissima qualità con una flessibilità di finanziamento unica (dollaro/mercato), ma deficit e interessi sono un vincolo strutturale che pesa sulla traiettoria di lungo periodo.
Dove s’inceppa la macchina: le difficoltà strutturali
Deficit “viscoso” (anche al netto dei cicli), maturità media non lunga, costo del servizio in accelerazione e domanda estera composita. La TBAC elenca anche gli effetti di policy (dazi, misure di spesa/entrata) sulle entrate e segnala che l’incertezza resta elevata sulle proiezioni 2026–2027. Il messaggio operativo è che l’offerta netta di Treasury resterà elevata su più trimestri, con Bills come cuscinetto e TIPS in leggero aumento per allargare la base.
I rischi di mercato: dal “term premium” alle aste difficili
Con una supply così ampia e persistente, il term premium può restare più alto e volatile lungo il 5–30 anni, specie se le aste lunghe mostrano tail sopra media o coperture meno “sticky”. Ogni scossone sulla duration si propaga ai tassi reali, che a loro volta comprimono i multipli equity (settori long-duration come tech e real estate) e allargano gli spread sul credito. In più, la liquidità non è uniforme: sugli off-the-run il premio di liquidità tende a riaprirsi nelle fasi di volatilità—e i buyback servono proprio a limitare queste dislocazioni, non a eliminarle.
Che cosa significa, in pratica, per chi gestisce portafogli
Bills vs “cuscinetto” di sistema. Con la RRP quasi drenata e il QT rallentato, i Bills restano ben assorbiti dai fondi monetari (che hanno WAM medio ~38 giorni a fine giugno, limite regolamentare 60). La domanda c’è, ma chiede un premio coerente con alternative di repo e SRF. Sulle scadenze leggermente più lunghe (13–26 settimane), il roll-down resta interessante finché i tagli Fed sono incerti e la curva resta “alta” sul breve.
TIPS e tassi reali. Il Tesoro sta aumentando gradualmente i TIPS: bene per diversificare la base e “spezzare” un po’ il beta dei real yield. Attenzione però: con l’inflazione core che fa fatica a rientrare, è il tasso reale a muovere i prezzi; nei drawdown i TIPS possono comunque soffrire via real yield in salita (anche se il breakeven tiene).
Aste, micro-liquidità e buyback. Nei periodi di settlement/tasse (quarter-end, date “pesanti”) il funding si tende: lo si è visto a metà settembre con SRF record. In quelle fasi conviene seguire bid-to-cover, tail e calendario buyback: esitazioni sul 20–30Y spesso si propagano subito a MBS e credito IG via tassi reali, e i buyback aiutano a ricucire gli spread su CUSIP meno liquidi.
Equity e credito. Con > $1 tn di interessi annui, ogni risalita dei rendimenti a lunga si traduce in de-rating dei multipli (soprattutto growth) e in spread più larghi—non necessariamente per deterioramento del credito, ma per la mancata compressione dei tassi reali. Per chi è long duration risk, la gestione tattica della curva e della componente reale diventa cruciale.
Conclusione: il premio a termine è il nuovo metronomo del rischio
Gli Stati Uniti restano l’emittente “core” del mondo: profondità senza eguali, liquidità e una domanda di base resiliente. Ma la combinazione deficit elevati + parete di scadenze ravvicinate + interessi in accelerazione rende lo shock d’offerta una caratteristica permanente del nuovo regime. Il Tesoro sta facendo molto sul lato offerta (QRA prevedibili, buyback di liquidità, più TIPS), la Fed ha modulato il QT, ma la traiettoria del debito è, in ultima analisi, fiscale. Finché non ci sarà un ancoraggio credibile dei conti, i mercati chiederanno un premio a termine più alto—ed è quel premio, oggi, a scandire il ritmo del rischio globale.