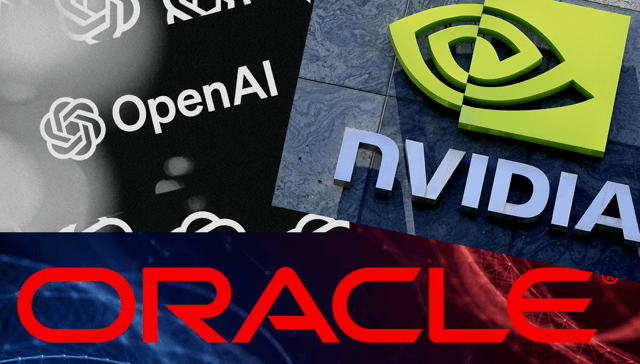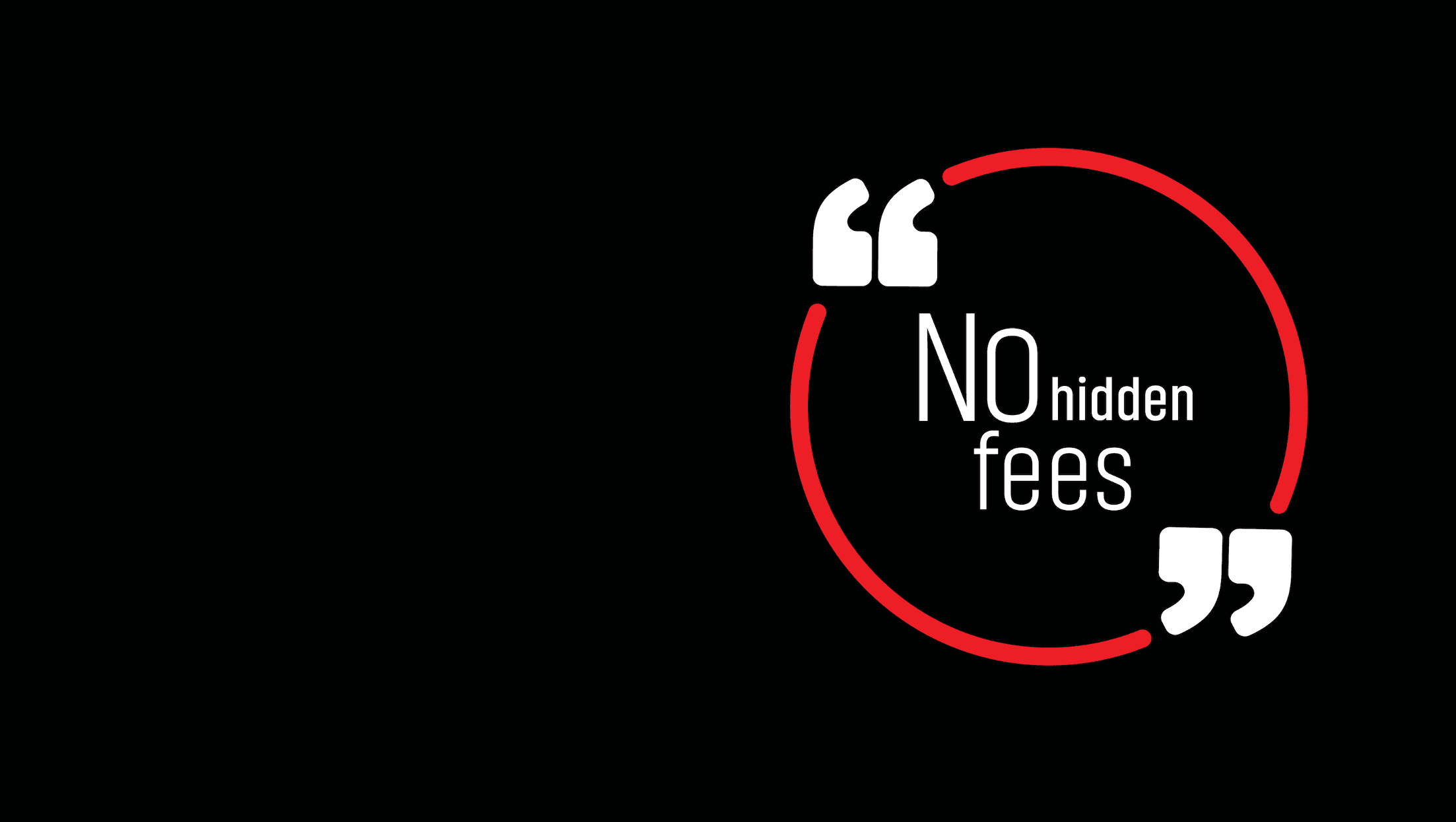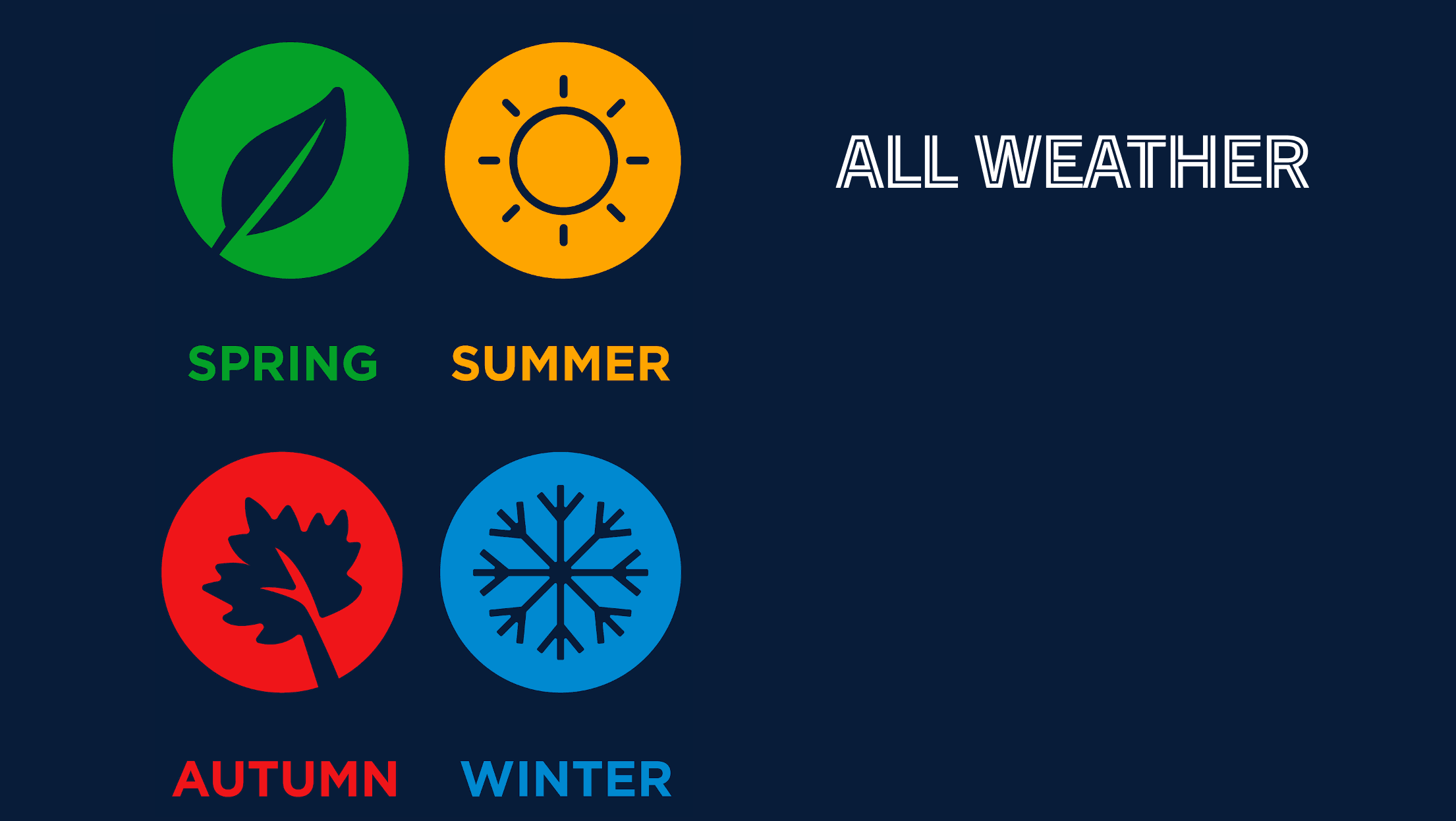Coacervo: il cardine invisibile della pianificazione successoria moderna
Nel linguaggio della pianificazione patrimoniale esistono termini che, pur sembrando tecnicismi per addetti ai lavori, determinano in realtà l’equilibrio e l’efficacia dell’intero passaggio generazionale.
Il coacervo è uno di questi. È una parola che raramente emerge nelle conversazioni tra famiglie e professionisti, e che pure rappresenta la struttura portante sia della corretta ripartizione tra eredi, sia della strategia fiscale e finanziaria più adatta a preservare la ricchezza.
Negli ultimi anni, complice la riforma fiscale e un’evoluzione giurisprudenziale ormai consolidata, la portata di questo concetto è cambiata, e oggi merita una lettura chiara e aggiornata. Non si tratta solo di definire cosa sia il coacervo, ma di comprendere come esso influisca sui legittimari, sulle donazioni, sulla tassazione, e in ultima analisi su tutte le scelte che una famiglia può compiere per tramandare il proprio patrimonio in modo ordinato, efficiente e armonioso.
Il coacervo civilistico: la bussola nascosta della successione
Nel diritto civile, il coacervo è un’operazione tanto teorica quanto indispensabile. L’articolo 556 del Codice Civile impone infatti di sommare ciò che resta nel patrimonio del defunto, il cosiddetto relictum, con quanto egli ha già donato in vita, il donatum. Questa ricostruzione, puramente aritmetica, non ha lo scopo di “riverificare” le donazioni, né tantomeno di rimetterle in discussione dal punto di vista sostanziale; serve piuttosto a determinare la massa sulla quale calcolare le quote di legittima e quella disponibile.
È da questa somma che nasce la domanda chiave: i legittimari hanno ricevuto ciò che per legge devono ricevere? Coniuge, figli e, in loro mancanza, ascendenti non possono essere privati della loro riserva. La riunione fittizia serve proprio a verificare se il defunto, con donazioni o scelte testamentarie, abbia ecceduto nella destinazione della porzione disponibile.
Un elemento spesso fonte di confusione è la differenza tra coacervo e collazione. Anche quando un genitore dispensa un figlio dalla collazione, cioè dall’obbligo di conferire ai coeredi quanto ricevuto in donazione, quella stessa donazione continua comunque a entrare nel coacervo civilistico. In altre parole, la dispensa vale per la fase divisionale tra coeredi, ma non elimina il controllo sulla legittima. Se una donazione ha superato la quota disponibile, potrà essere ridotta, anche a distanza di molti anni e anche se era stata accompagnata da una dispensa.
Per chi pianifica, questo significa che la vera sicurezza non deriva da formule notarili o da clausole ad effetto, ma da una ricostruzione rigorosa della massa di coacervo, dalla comprensione delle riserve e da una distribuzione equilibrata o almeno giustificabile. Una successoria ordinata nasce prima di tutto dalla matematica della legittima.
Il coacervo fiscale: ciò che è stato abrogato e ciò che rimane determinante
Sul fronte fiscale, il concetto di coacervo ha vissuto negli anni un’evoluzione importante. Fino a poco tempo fa, il fisco pretendeva che anche ai fini dell’imposta di successione il patrimonio relitto fosse sommato alle donazioni fatte in vita. Questa impostazione, già criticata dalla giurisprudenza, è stata definitivamente superata con il D.Lgs. 139/2024, che ha sancito la fine del coacervo successorio a partire dal 1° gennaio 2025.
Si tratta di un cambiamento tutt’altro che marginale. Oggi, quando si apre una successione, l’imposta viene calcolata esclusivamente sul patrimonio effettivamente presente al momento del decesso. Le donazioni pregresse non vengono più “riaggregate” ai fini fiscali. È una distinzione che separa nettamente il piano civilistico da quello tributario e che apre nuove possibilità nella distribuzione dei beni.
Esiste tuttavia un ambito in cui il coacervo fiscale resta pienamente operativo: l’imposta sulle donazioni. Ogni volta che un soggetto riceve una donazione, la franchigia disponibile non si resetta. Deve essere ridotta tenendo conto del totale delle donazioni già ricevute dallo stesso donante. È il cosiddetto “coacervo donativo”, previsto dall’articolo 57 del Testo Unico sulle Successioni e Donazioni. In buona sostanza, la franchigia per le donazioni è un contenitore che si riempie nel tempo, senza azzerarsi.
Questa doppia regola crea un sistema articolato ma potenzialmente molto conveniente:
– le successioni permettono di utilizzare una franchigia “intatta”, applicata solo sul relictum;
– le donazioni, invece, attingono a una franchigia a scalare, consumata nel corso della vita.
Capire come armonizzare questi due strumenti è oggi cruciale.
Franchigie e aliquote: un quadro stabile ma che richiede attenzione
Il sistema italiano mantiene franchigie piuttosto generose, soprattutto per i rapporti familiari più stretti. Coniuge e figli godono di una franchigia di un milione di euro ciascuno, oltre la quale si applica l’imposta al 4%. Fratelli e sorelle dispongono invece di una soglia di 100.000 euro e sono soggetti a un’aliquota del 6%. Più elevata, 1.500.000 euro, è la franchigia prevista per i soggetti con disabilità grave. Per tutti gli altri parenti e per gli estranei non è prevista alcuna franchigia, e l’aliquota sale rispettivamente al 6% e all’8%.
Se rapportate all’andamento del patrimonio medio delle famiglie italiane, dove una parte consistente è immobiliare e un’altra parte, crescente, è costituita da strumenti finanziari, queste soglie rappresentano un margine significativo di pianificazione, ma vanno utilizzate con precisione chirurgica.
Dove civilistico e fiscale si incontrano: la vera arte della pianificazione
La pianificazione patrimoniale è un territorio in cui diritto civile, fiscalità e finanza si intrecciano in modo delicato. La scelta di donare oggi, lasciare in eredità domani, strutturare una governance familiare o costruire un equilibrio tra figli non può prescindere da un’analisi simultanea di tutti questi profili.
Sul piano civilistico, ogni donazione, anche la più ben intenzionata, può essere perfettamente legittima dal punto di vista fiscale e allo stesso tempo potenzialmente lesiva della legittima. Prima di fare qualsiasi scelta, occorre ricostruire la massa di coacervo, individuare i legittimari, calcolare le riserve e determinare la reale quota disponibile. È un lavoro che richiede metodo e attenzione, ma che previene contenziosi tanto frequenti quanto dolorosi.
Sul piano fiscale, la distinzione tra coacervo successorio (abrogato) e coacervo donativo (invece pienamente operativo) crea opportunità nuove. In molti casi, la strategia ottimale non è donare tutto, né rimandare tutto alla successione, ma costruire una combinazione: donazioni mirate e funzionali alla gestione del patrimonio familiare, alternate a scelte testamentarie che valorizzino la franchigia successoria rimasta integra.
Strumenti evoluti e soluzioni eleganti
In questa prospettiva, strumenti da sempre utilizzati acquisiscono una nuova luce.
La donazione con riserva di usufrutto continua a rappresentare una formula equilibrata per trasferire la nuda proprietà mantenendo reddito e controllo. Le polizze vita restano uno dei pilastri più versatili del wealth transfer: escono dall’asse ereditario, non concorrono all’imposta di successione e consentono la designazione libera dei beneficiari. È vero, i premi eccessivi rispetto al patrimonio complessivo potrebbero essere scrutinati civilisticamente, ma in un contesto ben pianificato rimangono uno degli strumenti più raffinati; tuttavia è altrettanto vero che i costi che gravano su queste soluzioni, spesso mantenute per molti anni, possono erodere in modo significativo il rendimento, rendendole talvolta un’opzione eccessivamente onerosa rispetto ai benefici attesi.
Per le realtà imprenditoriali, i patti di famiglia restano la strada privilegiata per garantire continuità aziendale, assicurando nel contempo un equilibrio verso gli altri legittimari. Il testamento, infine, non è un orpello formale: quando è costruito con attenzione, diventa un elemento decisivo per governare un coacervo complesso e per dare forma a una volontà chiara e rispettosa delle regole.
Perché il coacervo non è un problema, ma un’opportunità
Guardando al quadro d’insieme, il coacervo non dovrebbe essere percepito come un intralcio tecnico. È, al contrario, un alleato prezioso: un meccanismo che permette di proteggere la famiglia, assicurare l’equità, ottimizzare la tassazione e prevenire contenziosi.
È la lente attraverso cui il patrimonio familiare rivela la sua storia: ciò che è stato donato, ciò che è rimasto, ciò che può ancora essere destinato in modo libero.
La pianificazione successoria, per quanto radicata nella matematica e nel diritto, resta un gesto umanissimo. Riguarda la cura per il futuro dei propri cari. Riguarda la capacità di trasformare il patrimonio in un progetto duraturo di serenità e continuità.
E in questa prospettiva, il coacervo, compreso nella sua doppia natura, civilistica e fiscale, diventa non un ostacolo, ma la chiave per costruire un percorso coerente, sobrio e lungimirante.
Perché, oltre le regole, ciò che conta davvero è la qualità delle scelte. E la consapevolezza che, anche in materia di eredità, la vera eleganza sta nella chiarezza.